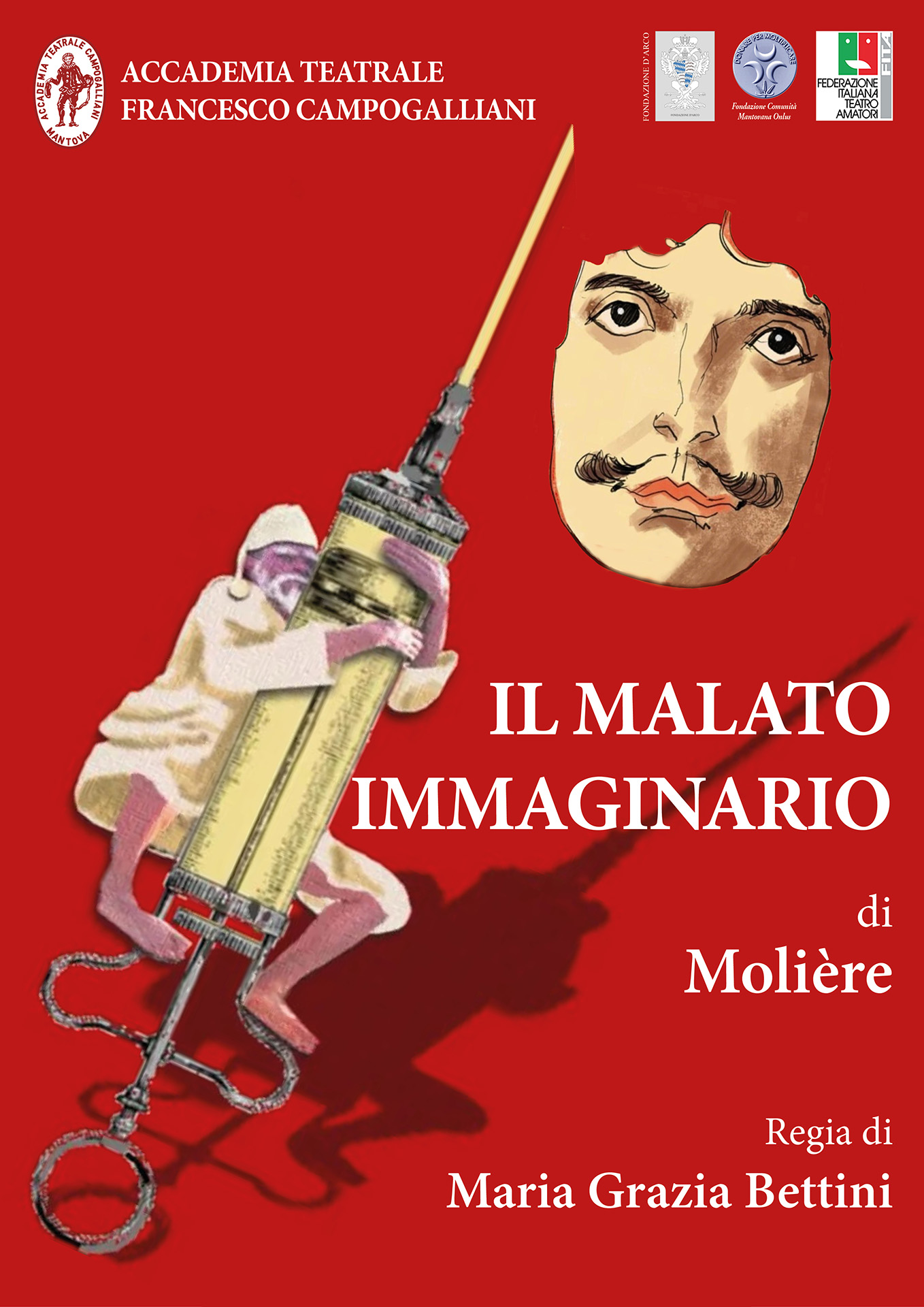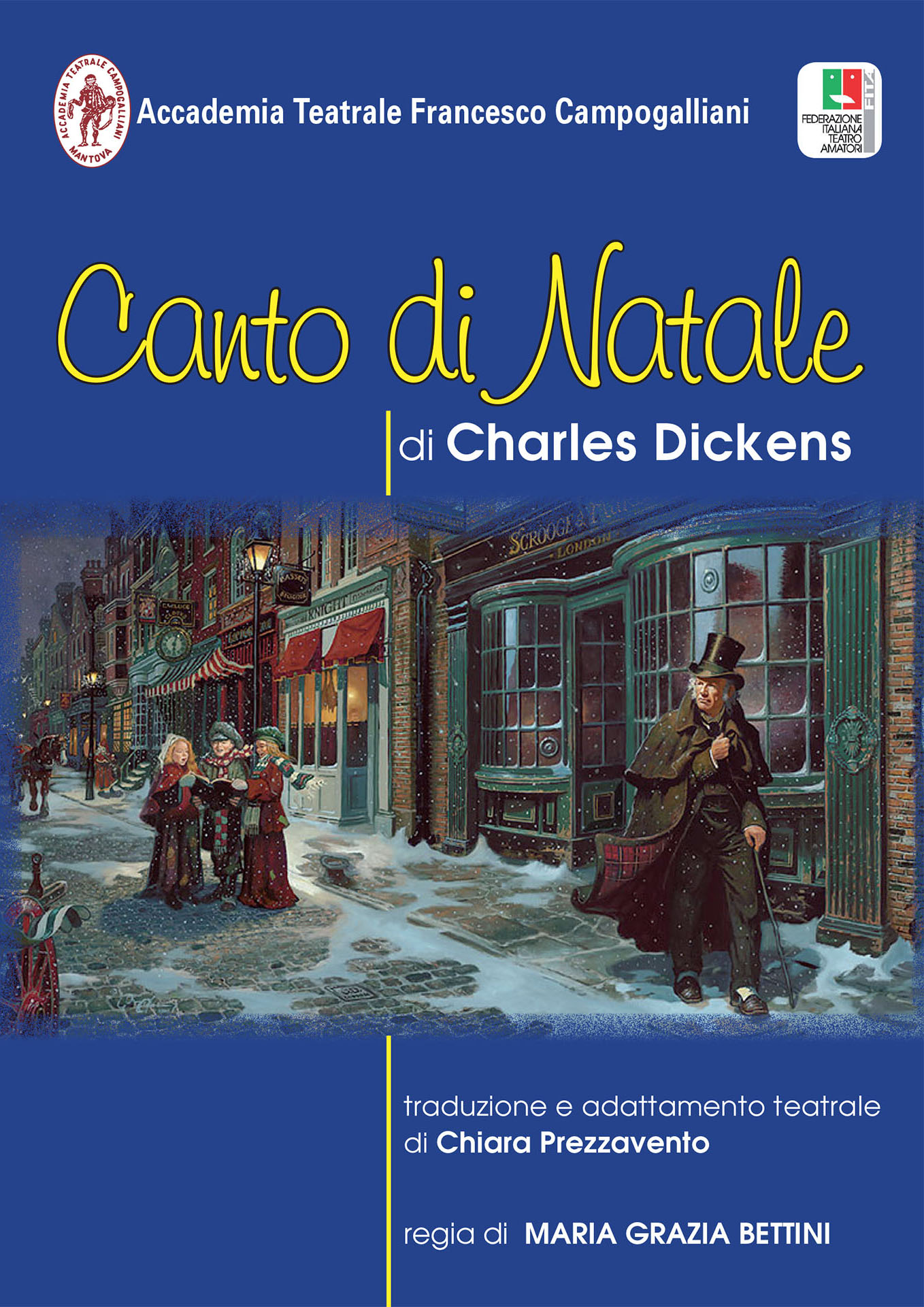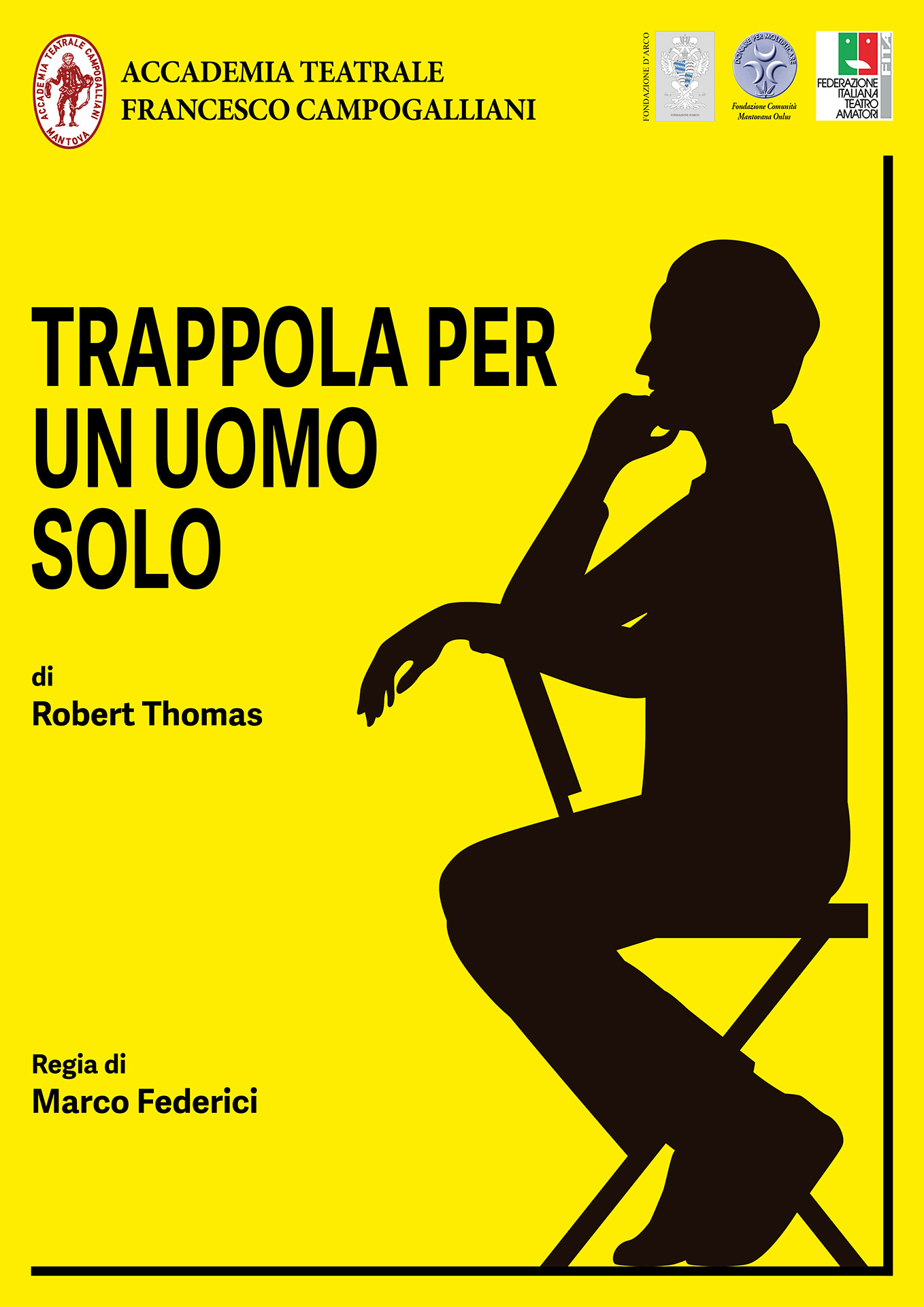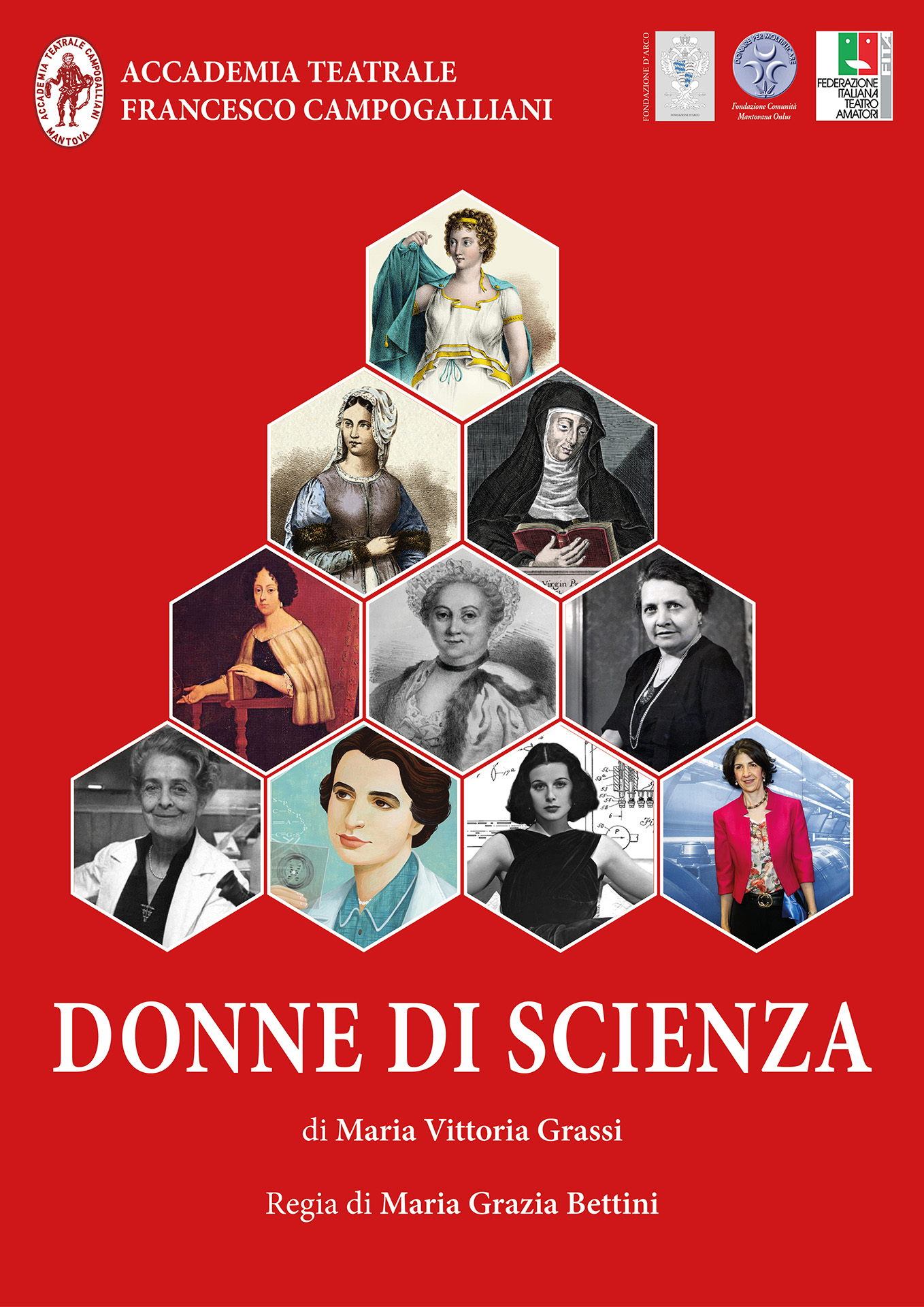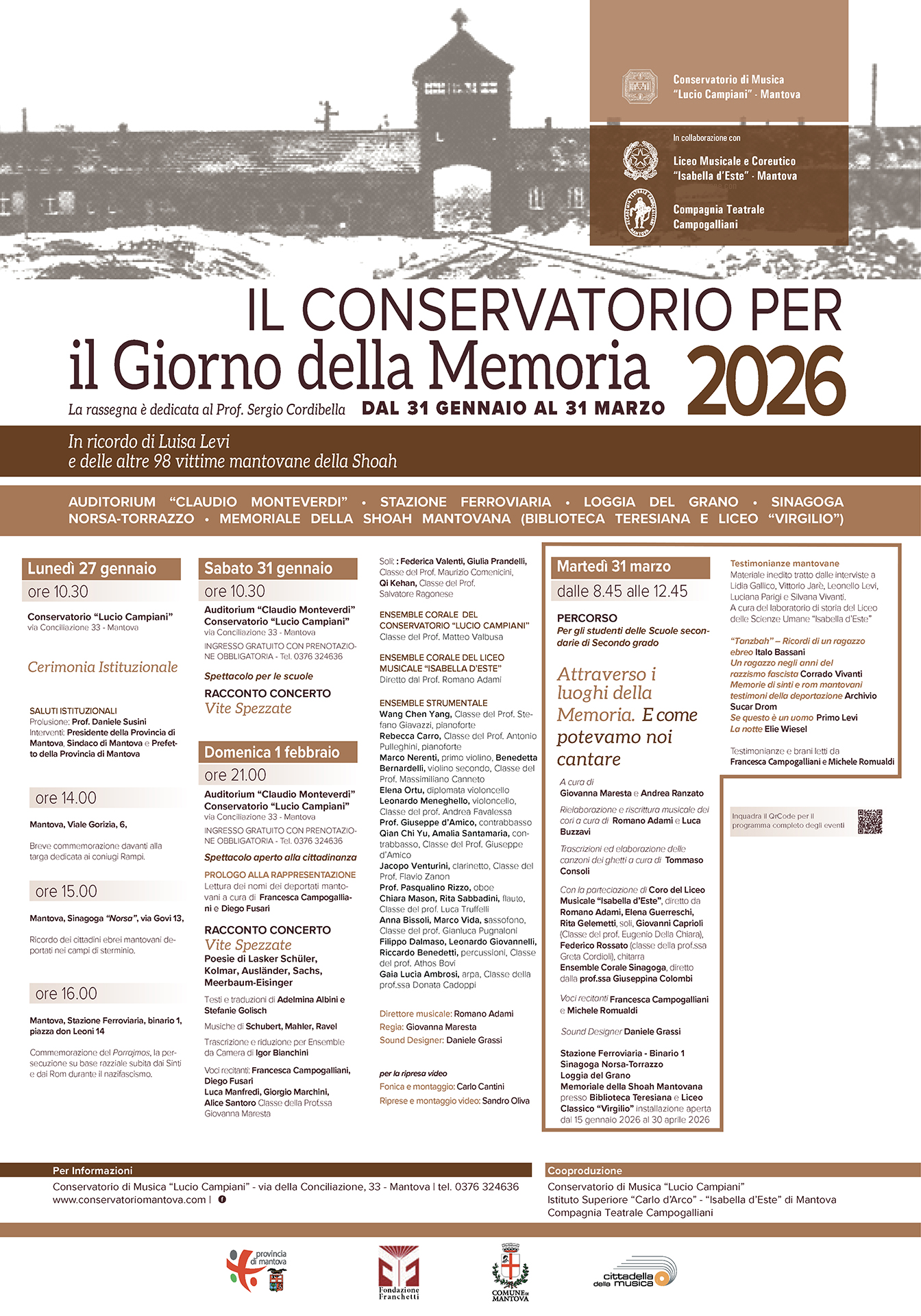IL MIO PREZIOSO ANGELO
SWEET SWEET SPIRIT
di Carol Carpenter
traduzione di Enrico Luttmann
Regia di Mario Zolin
Durata:
La pièce “IL MIO PREZIOSO ANGELO” racconta la crisi di una famiglia molto conservatrice, in una cittadina rurale del Texas, generata dalla complessità del rapporto con il figlio, Tyler: un ragazzo gay che ama vestirsi e comportarsi in modo eccentrico, manifestando così al mondo la sua diversità. Tyler è supportato dalla madre, Suzanne, un’alcolista col desiderio di diventare un’imprenditrice: questo è il suo sogno, nel quale si rifugia per evitare di guardare in faccia la triste realtà in cui vive. La passione sfrenata per suo figlio la porta ad assecondare in tutto e per tutto le tendenze di Tyler, che diventa un po’ il suo compagno di giochi, come la bambola per una ragazzina, quella che in fondo lei è, una donna mai cresciuta. Il dramma scaturisce nel momento in cui Jimmy, padre dell’adolescente Tyler, del quale lui da sempre mal sopporta il suo modo d’essere, tornando a casa trova il figlio a letto con un uomo della sua età e in un raptus di rabbia lo massacra di botte tanto da ridurlo in coma. La seconda parte della pièce si svolge in ospedale, dove le diverse generazioni dei famigliari di Tyler sono spinte a guardarsi dentro e a cercare risposte nuove, inimmaginabili. L’ospedale dove Tyler lotta tra la vita e la morte, sarà luogo d’incontro e di scontro dei componenti della famiglia: lì si rinfacceranno le reciproche debolezze, contendendosi la custodia di Tyler. Nanna Jo, la nonna, protagonista assoluta della pièce, molto religiosa e conservatrice, ma anche teneramente affezionata al nipote, sua figlia Jennifer, donna in carriera, troppo schietta e pragmatica. E infine Kenny, compagno di liceo di Jimmy, che subì da questi le stesse violenze subite da Tyler.
NOTE DI REGIA
Ho scelto di portare in scena questo testo sconosciuto in Italia perché l’autrice ha scritto un dramma penetrante, devastante, una storia commovente e attuale, dove il protagonista Tyler, pur non comparendo mai durante l’intero arco della rappresentazione, è sempre presente come forza unificante. Carol Carpenter nella sua pièce ha saputo creare personaggi credibili, proponendoci un dramma di parola, dove ogni personaggio delinea sé stesso donandosi al pubblico, che potrà così, alla fine, giudicarlo. Ed è proprio nello studio dei vari personaggi, nello studio delle intenzioni nelle singole battute che ho lavorato con gli interpreti, cercando di creare quella tensione che l’autrice ha immesso nella sua scrittura, in un crescendo che si conclude con un finale emozionante. La scenografia è essenziale, richiama i luoghi degli avvenimenti senza sovrastare la potenza del dramma.
L’AUTRICE
CAROL CARPENTER è nata nell’America del sud in una famiglia religiosa, ha dichiarato la propria omosessualità all’età di 18 anni, è cresciuta poi nel Nuovo Messico, dove la Bibbia, il confine messicano, le raffinerie di petrolio, i cowboy e i poveri si incontrano a formare un paesaggio fatto di conflitti. Nei suoi scritti afferma che il progresso e la tradizione hanno bisogno l’uno dell’altro, che senza l’armonizzante effetto degli opposti il nostro mondo è squilibrato. Vive tra New York e Madrid.
AUTORITRATTO
Scrivo di rednecks, battisti, messicani, immigrati, petrolio, ranch, narcotraffico, prigioni, povertà, politici, cowboy, imprenditori (e dei liberali benintenzionati che li fanno correre a prendere le armi). Scrivo della frontiera. Sono cresciuta nel Permian Basin, il bacino petrolifero più ricco degli USA, in una città dove ha sede l’accademia di addestramento della Border Patrol. I miei genitori erano battisti della classe operaia e democratici liberali. Ho un master in scrittura drammaturgica alla USC, ho lavorato alla Paramount, scritto romanzi per ragazzi per Random House (sotto lo pseudonimo Amanda Christie), e ho fatto la drammaturga a New York per un decennio. Ho lasciato il settore nel 2016, dopo essere stata selezionata come Writers Lab Fellow, per prendermi cura di mia madre dopo la morte di mio padre. Ora sono tornata. Sono forse l’unica liberale urbana che è rimasta legata alla sua famiglia religiosa e conservatrice. Oscillo con disinvoltura tra il mondo del petrolio e l’università dove insegno. Amo e detesto entrambi. Questo doppio sguardo dà realismo e universalità al mio lavoro. Pensate a Taylor Sheridan, ma con donne intelligenti, liberali e (veri) cristiani. Scrivo della “vera America”, perché ci siamo dentro tutti, ugualmente sciocchi, saggi, crudeli e gentili.